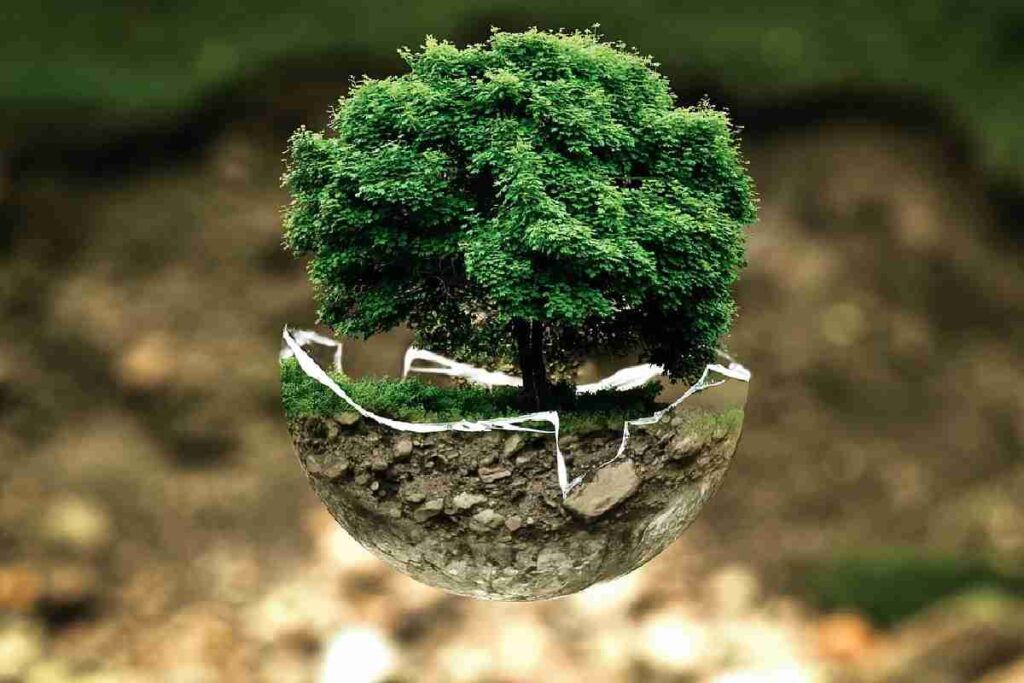Italialaica.it

In Olanda una 28enne malata di depressione morirà di eutanasia: cosa ne pensa il resto d’Europa?
Zoraya ter Beek, malata di depressione maggiore, si sottoporrà ad eutanasia il prossimo mese. Ma l’Europa cosa pensa di questa possibilità? Nei giorni scorsi una …
Cultura
Milena Vukotic non ha fatto solo Fantozzi: la carriera della vincitrice del David di Donatello
L’eccezionale talento di Milena Vukotic, nata a Roma nel 1935 ha illuminato il panorama cinematografico … Leggi tutto
Niente Eurovision per Loredana Bertè: a San Marino vincono i Megara
Niente Eurovision per Loredana Bertè: a San Marino vincono i Megara, la band spagnola di … Leggi tutto
Il Bugo gate arriva in tribunale, respinto un risarcimento da tremila euro
Morgan si difende: “Ma che tragedia sta mettendo giù Bugo? Mi denuncia per diffamazione e … Leggi tutto
Shōgun, su Disney+ arriva la serie tratta dal libro di James Clavell
Presentata con uno spettacolare trailer nella serata del Super Bowl, Shōgun , la nuova serie … Leggi tutto
I registi di “My favourite cake” dedicano il film alle donne iraniane
La storia del cinema iraniano racconta quanto sia difficile per i registi arrivare sui palchi … Leggi tutto
La tutela dell’ambiente fa parte della Costituzione, ma molti italiani non lo sanno
Quanto ne sanno i cittadini italiani della riforma del 2022 e quanto ritengono che sia … Leggi tutto